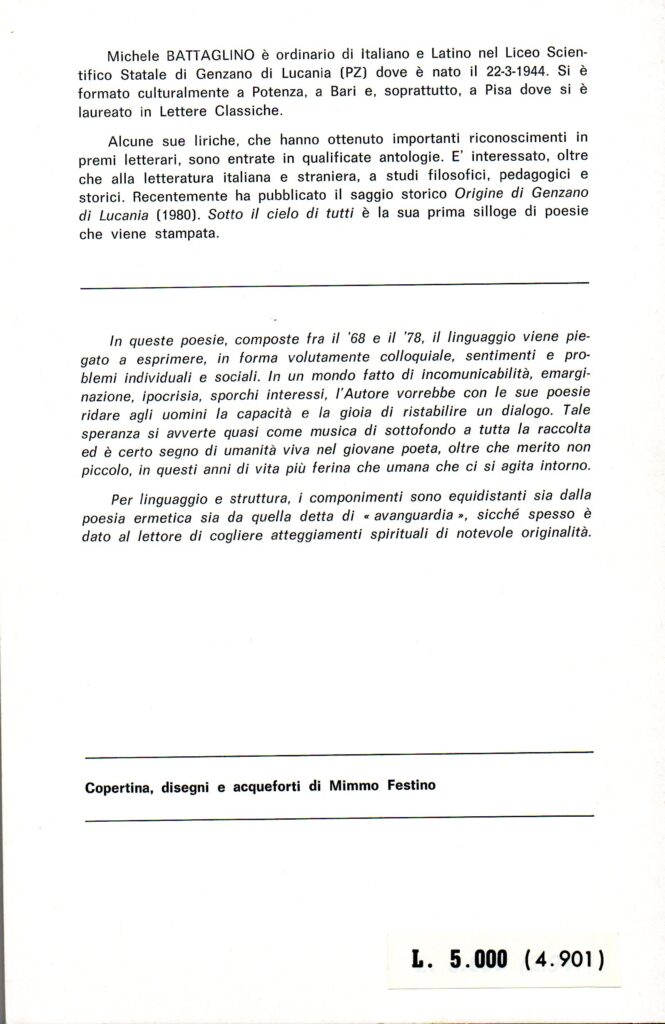Sotto il cielo di tutti
Queste poesie (composte nel decennio 1968-1978) mirano a recuperare i sentimenti e i valori della gente comune, rompendo il muro di incomunicabilità, emarginazione, ipocrisia che ci circonda e ridando agli uomini la capacità e la gioia di ristabilire un dialogo. Il recupero è operato con un’adesione spirituale del poeta, che si mantiene sempre tra commozione e autocontrollo, e con una lingua volutamente colloquiale. Per stile e struttura, le liriche sono equidistanti sia dalla poesia ermetica sia dallo sperimentalismo della Neoavanguardia. Il linguaggio, pur così naturale, è frutto di una lunga frequentazione dei poeti greci e latini e della migliore letteratura del Novecento, nostrana e straniera; sicché spesso è dato di cogliere atteggiamenti spirituali ed esiti artistici di notevole originalità.
Sotto il cielo di tutti
- Grazia FIDECICCHI, «Corriere delle Arti», 2 (agosto-settembre 1981), n. 15, p. 7)
- Enrico SCHIAVONE, «Incontri», n.s., VIII (ottobre 1981), n. 9, p. 7 s.
- Mirella TAVERNA, «Sìlarus» [rassegna bimestrale di cultura], XVII (novembre-dicembre 1981, n. 98, p. 80)
- Angelo BATTAGLINI, «Scuola Snals» [settimanale del sindacato nazionale autonomo lavoratori scuola], VI (31 dicembre 1981), n. 42, p. 3
- IPPONATTE, «Alla bottega» [rivista bimestrale di cultura ed arte], XX (gennaio-febbraio 1982, n. 1, p. 61)
- Italo GHIGNONE, «Dimensione» [bimestrale della Banca Popolare Coop. di Pescopagano], 3 (giugno-luglio 1982), n. 4, p. 85
- Bruno ROMBI, «Il ragguaglio librario», n.s., (settembre 1982), n. 9, p. 324
- Mario GORINI, «Contrappunto» [rivista di poesia ed arte], VII (luglio-ottobre 1983), n. 4-5, p. 44
- Enzo CONCARDI, in Scrittori italiani del II Dopoguerra. La poesia contemporanea, con prefazione di Bruno Maier, Milano, Guido Miano editore, 1985, p. 263 s.
- Santino G. BONSERA, relazione del 4 agosto 1985, tenuta a Genzano di Lucania
- Italo GHIGNONE, recensione inedita, 22 marzo 1982
[…] La sostanza della raccolta si sviluppa gradatamente incanalata come è in quattro sezioni (Diario I, Sotto il cielo di tutti, Diario II e Ripresa) e giunge alla conclusione prefissa senza digressioni e senza squilibri.
Il tono lirico più elevato e più impegnativo di questa poesia non intima ma sociale, nel senso di recupero di valori morali individuali, come giustamente scrive nella presentazione Raffaele De Lauro, è da ricercarsi nel poemetto Sotto il cielo di tutti, che dà il titolo alla raccolta, composto nell’aprile-maggio di quel 1969 che vide l’umanità tragicamente in armi (guerra arabo-israeliana, guerra del Vietnam) in cui la valutazione umana di quei tristi avvenimenti è magistralmente adattata alla gradazione musicale del verso, che s’innalza fino a toccare punte di elevato vigore nella dura condanna della fame, del razzismo e della guerra, piaghe eterne di cui però ogni uomo è responsabile.
Forza lirica questa del Battaglino sorretta da un sicuro senso artistico, ragione per cui l’eleganza della forma e l’eloquenza dello stile consentono una costruzione di ampio respiro, che si sviluppa traducendo pensieri e sentimenti in vivide immagini delineate su uno scenario composito su cui domina l’afflato umano. […]
La poesia di Michele Battaglino, pur coi suoi caratteri particolari, relativi alla personalità dell’autore, si inserisce, tuttavia, in modo evidente nel corso delle esperienze moderne e sembra raccogliere quanto è stato definitivamente acquisito dopo i molteplici tentativi che vanno dall’ermetismo alle più recenti ‘avanguardie’.
Il succo di tante rivolte è stato il superamento del ‘petrarchismo’, del ‘canto’, la conquista di un nuovo linguaggio poetico in cui la parola soprattutto acquista rilievo e si carica di significato. Appunto questa rinnovata sensibilità è senza dubbio presente nella poesia di Battaglino.
Il linguaggio dal tono prevalentemente parlato o magari dimesso deriva da un attento rifiuto dei toni aulici, perché si concentra piuttosto sulla essenzialità e intensità dell’espressione, sulla rapidità dell’immagine. Da ciò dipende la facile, immediata comunicazione dell’ampia gamma dei motivi che urgono nello spirito del poeta. Questa concentrazione è anche ottenuta mediante strutture sintattiche spesso fortemente legate che si sviluppano in una continuità densa e serrata.
[…] I motivi principali ricorrenti nel libro sono: la memoria dell’infanzia e dell’adolescenza, la donna, la famiglia, il paese, il razzismo, l’antimilitarismo, l’emigrazione, la politica, la guerra, la pace. Sono i temi dell’epica quotidiana variamente svolti, a volte con un tono affettuoso, colloquiale ed a volte con impennate polemiche magniloquenti.
Nel sottofondo del poeta però s’avverte un’amorosa nostalgia per una vita moralmente sana, fatta di cose semplici e di schietti sentimenti umani. Battaglino ha indubbiamente una naturale disponibilità d’immagini che danno un vivace colorito alla rappresentazione degli ambienti e delle situazioni e gli permettono di rivivere liricamente con elegiaco intenerimento le figure e i luoghi della sua Lucania.
La poesia di Battaglino nasce come ricerca sofferta e come duro impegno; non zampilla, ma si genera dalla viva tensione morale e spirituale del poeta, che ha una severa concezione della poesia e della vita. Se è vero (come alcuni critici hanno messo in evidenza) che la sua poesia si colloca al di là delle esperienze ermetiche, è anche vero che egli non rifiuta del tutto la lezione dell’ermetismo, almeno nella richiesta di impegno totale. Ricordo, a questo proposito, la famosa affermazione di Carlo Bo: ‘letteratura come vita’. In fondo è la stessa petizione di principio che avanza Battaglino in quel componimento che sembra essere il suo programma di poeta, la sua poetica.
E’ la lirica intitolata All’amica poesia (p. 67), che chiude la raccolta. In genere, la dichiarazione della propria poetica, nella disposizione delle pagine, è posta all’inizio della raccolta; ma qui è messa alla fine. E non senza ragione. Tale collocazione, che potrebbe sembrare un semplice fatto tipografico, è invece il segno della funzione che Battaglino assegna alla poesia ed è, allo stesso tempo, la richiesta che egli fa al lettore di esercitare liberamente la propria intelligenza e di risvegliare la sensibilità verso i messaggi, senza dover seguire i binari tracciati dall’autore. In questo componimento il poeta esprime a chiare note il concetto che la poesia è una conquista intellettuale, non un dono gratuito delle muse, le quali (come già aveva cantato Sinisgalli, un nostro grande poeta caro al Battaglino, che alla poesia del Montemurrese ha dedicato recentemente un saggio critico) ormai sono animali che gracchiano, «appollaiate […] / tra le foglie larghe delle querce» intente a «mangiare ghiande e coccole» (Vidi le Muse, vv. 3-6): le muse non abitano più sull’Elicona per ispirare il poeta. Il poeta, secondo Battaglino, deve trovare nei fatti e nelle condizioni morali, sociali e storiche del tempo il suo mondo poetico («nelle pieghe della vita e della morte, / non fuggendo lontano, ma scavando / nelle miniere nostrane», vv. 8-10). La poesia, dunque, non è consolazione solipsistica né esercizio retorico; è piuttosto un impegno – particolarissimo e nobile – di servizio nel sociale; è la richiesta di solidarietà e di amore per chi soffre.
Al centro della poesia di Battaglino, infatti, v’è l’uomo. Non a caso, nell’intestazione del poemetto che dà il titolo al libro è riportata un’affermazione di Seneca: homo sacra res homini. Battaglino ricerca la poesia «nelle lacrime non versate di tanti / per la strada» (v. 5 s.), cioè nel dolore chiuso e inespresso della gente comune, quella che si incontra per strada. Il poeta sembra essersi assunto il compito di sollevare, con delicato e pietoso sentimento, il velo sui drammi segreti che gli uomini rinserrano nel proprio cuore, carpendoli alla diffidenza dei sofferenti, di chi si chiude in sé, incapace di aprirsi e di credere nel fratello.
I temi della solitudine, della incomunicabilità, della emarginazione, della cattiveria che l’uomo esercita sull’altro uomo – temi che sostanziano prevalentemente questa silloge – credo siano espressi in modo esemplare ne La vecchietta del caffè (p. 24). Qui, con pochi tratti l’autore riesce a descrivere una condizione esistenziale trascinata tra la derisione degli avventori del caffè e la stanchezza fisica, che è poi il riflesso di una stanchezza più profonda, la stanchezza del vivere o forse di vivere, che si coglie nell’indifferenza dei gesti: indifferenza alla vita. La solitudine risalta in quella premura per la gatta, che è – e non soltanto allegoricamente! – sostitutiva di un rapporto umano. Il rapporto esclusivo e totalizzante donna-gatta è la minimizzazione (ed anche la depravazione) di sentimenti per i quali l’uomo è uomo, e la vita si vive – pur nella sua pena – al più alto grado delle possibilità. La presenza dell’animale esacerba quella mancanza ed infonde una infinita tristezza. E io non posso fare a meno di rintracciare lontani echi leopardiani: questa vecchietta che alla vista di giovani amanti ricorda la sua giovinezza consunta nella vana attesa dell’amore, illanguidendo nel desiderio sempre frustrato di un amore, mi fa spontaneamente pensare a quell’altra più famosa vecchierella de Il sabato del villaggio. Certamente, nella poesia di Battaglino la situazione è diversa. In Leopardi vi è il momento consolatorio della rimembranza; nella vecchietta di Battaglino invece c’è il ricordo di sogni d’amore mai realizzati, che rende più triste e desolata la vecchiaia; la vecchierella leopardiana ha di che e con chi novellare; questa sguattera di caffè, invece, non ha chi l’ascolti, ma vive nella più completa solitudine.
A differenza di Saffo, la constatazione che «virtù non luce in disadorno ammanto» (Ultimo canto di Saffo, v. 54) nell’animo di questa vecchietta non genera alcun drammatico conflitto. Ella vive accettando il suo amaro destino, senza rivolte e senza invidia: «Ma rancore non serba e, attraversando / il viale degli amanti, ai due felici / gira gli occhi che avrebbero acceso / fusti d’uomini, fosse stata bella» (vv. 25-28).
L’occhio del poeta abbraccia tutto l’ecumene. Ove sta l’uomo, lì vi è sofferenza. Soffrono l’americano e il vietnamita, il bianco e il negro, tutti accomunati nelle pene che l’uomo infligge a sé stesso. Il cielo è di tutti, siamo tutti uguali. Tuttavia, l’uomo tende ad escludere da questo cielo l’altro. Sotto il cielo di tutti (pp. 33-36), il lungo componimento poetico che dà il titolo all’intera raccolta, è la sintesi della moralità del poeta e dei suoi temi sociali. Questo testo è collocato a metà della raccolta perché fa da spartiacque tra le poesie di Diario I (che sono di memoria, di esperienze adolescenziali o di impressioni di vita comunque vissuta) e quelle successive, i cui temi sono di viva attualità: la fame, l’emarginazione, la miseria morale delle bidonvilles, la discriminazione razziale, i massacri e i genocidi, le guerre.
E’ una umanità derelitta, allontanata dai quartieri opulenti delle città, perché la presenza di cenciosi ed affamati è un’accusa alla società del benessere. Battaglino si piega pietoso anche sulle aberrazioni e sulle degradazioni a cui questi uomini sono spinti dalla cattiveria e dalla insensibilità di altri uomini, perché per il poeta homo sacra res homini. In questi versi par di sentire echeggiare pagine memorabili del migliore Zola; solo che qui la disposizione d’animo è diversa: è di pietà e di comprensione per i derelitti, incolpevoli delle loro stesse colpe.
Le possibili ascendenze culturali, alle quali ho fatto riferimento, mettono in evidenza il complesso reticolo culturale su cui Battaglino intesse le sue tele; reticolo che si snoda dalle aree dei classici latini e greci sino ai territori più vicini a noi. E proprio questa educazione letteraria, classica e moderna, conferisce alla lingua poetica una misura ed un controllo che nulla concedono agli artifici retorici. Il registro linguistico è volutamente colloquiale e consente una presa diretta e immediata sulle cose. Il dettato poetico non trascende, non forza mai le possibilità dell’espressione verbale, perché la sua poesia non sussurra, ma, parlando ad alta voce una lingua apparentemente negletta e quotidiana, più che alludere dichiara.
La poesia di Michele Battaglino, pur coi suoi caratteri particolari, relativi alla personalità dell’autore, si inserisce, tuttavia, in modo evidente nel corso delle esperienze moderne e sembra raccogliere quanto è stato definitivamente acquisito dopo i molteplici tentativi che vanno dall’ermetismo alle più recenti ‘avanguardie’. Il succo di tante rivolte è stato il superamento del ‘petrarchismo’, del ‘canto’, la conquista di un nuovo linguaggio pratico in cui la parola soprattutto acquista rilievo e si carica di significato. Appunto questa rinnovata sensibilità è senza dubbio presente nella poesia di Battaglino. Il linguaggio dal tono prevalentemente parlato o magari dimesso deriva da un attento rifiuto dei toni aulici, perché si concentra piuttosto sull’essenzialità e intensità dell’espressione, sulla rapidità dell’immagine. Da ciò dipende la facile, immediata comunicazione dell’ampia gamma dei motivi che urgono nello spirito del poeta. Questa concentrazione è anche ottenuta mediante strutture sintattiche spesso fortemente legate che si sviluppano in una continuità densa e serrata. Si osservi, ad esempio, il componimento intitolato Quello che rimarrà. Altrove, come in Morte di persona cara, il motivo poetico si delinea rapido e breve, con la preziosità del frammento.
Abbiamo accennato alla varietà dei contenuti nella poesia di Battaglino; e in verità rileviamo in essa un continuo, commosso, ma equilibrato rapporto fra il poeta e il mondo, fra il poeta e la vita. Non puro intimismo, dunque, ma costante apertura verso l’umanità, donde provengono le occasioni, gli impulsi che alimentano il lirismo di questo poeta, lirismo intenso, ma non gestuale ed effusivo. Troviamo anzitutto largamente presente il motivo esistenziale del tempo e del suo inesorabile trascorrere: «Metamorfosi della vita: / d’un balzo tutto è mutato, / finito, / e vano resta il rimpianto»
(Metamorfosi).
Dal sentimento del tempo e delle lontananze, in cui si perdono persone ed eventi, scaturiscono una profonda malinconia e, in modo particolare, il grande motivo della memoria: «Nella mente batte ora ronzio / di anni: la vista s’annebbia, / s’accavalla il passato. Invano / cerchi il ragazzo d’allora./ Nel ricordo è il tuo solo rifugio» (Passato e presente).
Poesia di memoria significa assoluta soggettività, intensa liricità, come quando, ad esempio, il poeta, chiudendosi in un momento di meditazione, si trova, quasi leopardianamente, nonostante la profonda differenza del linguaggio poetico, a contemplare la vanità dei sogni di cui si nutre la vita:
«Solo un giorno / il tempo di un respiro / e non vedo più la sottile / fila dei castelli di ieri / costruiti pietra su pietra, / gli allettanti miti…» (Il tempo).
Ma accanto al passato c’è la vita presente colta nei più vari aspetti, nei quali si manifestano principalmente i mali del mondo senza che tuttavia al poeta venga meno il sentimento della speranza. La lunga lirica Sotto il cielo di tutti è l’esempio più chiaro di quest’apertura. Così anche le tristezze che derivano dagli incontri umani sono spesso presenti in questa raccolta. Infatti, il poeta non si astrae mai dal mondo per ridursi a una realtà circoscritta, ma intesse un dialogo costante con gli altri in un rapporto continuo di simpatia e di compassione. Non deve calare il silenzio: «Qualche passante si fermerà / e in due o tre il cammino / avrà un sapore» (Se cala il silenzio).
Il mondo poetico di Battaglino si comunica, abbiamo detto, soprattutto mediante le immagini. Il momento emotivo si traduce in attimi di vita nei quali, per così dire, prende forma e diventa vivo ed evìdente. Poesia, quindi, che tocca senza diaframmi intellettualistici la sensibilità del lettore, limpida e prontamente intelligibile, frutto indubbio, oltreché di una vocazione, anche di esperienza e cultura. In ciò forse sta il segreto per cui le cose dette con quella sapiente semplicità, che fa pensare a certi frammenti eolici, vivono nel verso che trema di malinconia, mentre la parola si fa poesia: «Il malato alla finestra costruisce / a poco a poco l’estate / di domani, la sua luce,/ il grande brulichio della marina» (Dalla finestra):
Per questo ci pare che la raccolta di Battaglino sia una voce che, nel concerto non sempre intonato di tanta produzione poetica moderna, merita di essere ascoltata.
Bologna, 22 marzo 1982
Sotto il cielo di tutti
«Homo sacra res homini»
(Seneca, Ep. ad Luc., 95)
Non s’ode più per strada strimpellare
di accattoni, chiedere silenzioso
di donne con la mano tesa
nell’aria tra passanti distratti:
in città vivono auto veloci,
colletti inamidati, turisti.
La fame con cenci rappezzati,
sfrattata da superbi grattacieli
e boulevards in fiore di Parigi
e Roma, si ritira vergognosa
in catapecchie di periferia
tra promiscuità di letti.
E nel silenzio di fredde notti
al riparo di lacere coperte
ascolta gemiti trattenuti
di donna ancora fanciulla
sotto il sudore di mani callose,
mentre la mamma nell’altra capanna
vende abitualmente l’ultima
giovinezza per un pezzo di pane.
Forse per questo l’uomo talora
– quando dorme su cuscini di piuma
o lungo spiagge s’abbandona al sole
o ride sotto il cielo di tutti –
si vergogna d’essere uomo.
(p. 33)
[…]
Paternità
Non c’è oggi il pieno. Il respiro
è sereno e la mente già lontana
dai labirinti della politica
e della cronaca che mi porta
il giornale, ora smembrato
sulla sabbia e calpestato. Laggiù,
incerto ancora un po’ sui piedi
il mio bambino col secchiello d’acqua
e il pisellino al sole
spazia sulla battigia e non ha uguali:
il mare lo lambisce, ove si specchia
il biondo dei capelli e la certezza.
Allungo allora la mano
alla mano della madre qui accanto
e tutto si fa tenero e lontano.
(p. 55)
Madre
Fuori di casa scotta
la gradinata nell’agosto. In piedi
lassù aguzzi l’occhio,
ma tremito di mano
sempre fallisce la cruna.
Vivace
nipotina ti soccorre in un attimo
e m’è pena infinita.
(p. 59)
Giovane del Sud
Sotto l’ombra dei balconi
e dei giardini, lucertola al sole,
porti ancora nei visceri la pigra
fatalità, la flemma monocorde
dei nostri canti antichi
e logori il presente
senza attesa di futuro.
O rintanato al fumo
tagliagola dei caffè
riscaldati, nel crocchio degli habitués,
ogni energia sciupi ai quattro venti
disavvezzo a pulegge, aratri e libri
la mente avvolta tutta in ragnateli.
Come freddo l’inverno
e buia la tua strada!
E non ti scuoterà le vene un lampo
che t’immetta nel gorgo della vita?
(p. 62)
TRACKS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sodales rutrum blandit. Curabitur laoreet a neque at ornare. Quisque sem dui, efficitur et convallis nec, congue at leo. Donec vitae pulvinar sapien. Aenean lorem nulla, placerat quis risus at, faucibus imperdiet turpis. Mauris pellentesque vel est eget efficitur. Phasellus viverra enim at laoreet suscipit. Aenean pulvinar aliquam aliquam. Cras vel felis quis tortor molestie vehicula ac quis enim. Donec vitae felis feugiat, imperdiet est a, consectetur quam. Suspendisse auctor dignissim tellus a posuere. Vestibulum suscipit ullamcorper enim, imperdiet pretium neque rutrum id. Nunc placerat bibendum ipsum nec mattis.